Non è vero che un bambino di 5, 6 o 7 anni ha bisogno di fare sport all’interno di strutture specializzate. In un’età così giovane, necessita soprattutto del gioco, questo almeno fino all’adolescenza. In Italia, in un tempo neanche troppo remoto – anni Settanta del Novecento e parte del decennio successivo – i bambini che giocavano a calcio lo facevano essenzialmente nei prati, negli oratori, nei campetti di quartiere, nei cortili, se non per strada. Erano questi gli ambiti che assolvevano alla funzione di vivai. Il calcio e la sua connotazione sociale procedevano di pari passo. Anche quando piuttosto piccolo, era il bambino a scegliere di giocare a calcio, non c’era qualcuno a imporglielo, ed era tutto un liberarsi di fantasia e intraprendenza, l’apprendimento coincideva con il gioco stesso, mentre i compagni più esperti o più grandi davano il là quanto a stop, controllo palla, marcature ma anche – perché no? – quanto a dribbling, scivolate, affondi e colpi di testa.
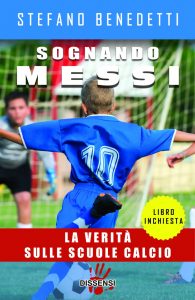
La situazione comincia a cambiare alla fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, quando le scuole calcio – fino ad allora fenomeno piuttosto circoscritto e legato ai grandi club – diventano una realtà sempre più numericamente evidente e, progressivamente, sempre più orientata al business e al profitto. Nel 2013 sono quasi 7200, con rette d’iscrizione che vanno dai 300 ai 900 €. Come hanno fatto a proliferare in maniera così esponenziale? Il sospetto di un che di improvvisato sorge più che legittimo e la poca qualificazione degli istruttori non fa che avvalorarlo. Diversamente dalla preparazione altamente specializzata dei coach delle squadre di campionato, coloro che dovrebbero insegnare il calcio ai bambini risultano più che altro dei “guardiani del gioco”, in prevalenza sprovvisti di nozioni certificate in scienze motorie, pedagogia infantile, tanto meno in psicologia, che allenano sotto la scure della quota d’ammissione, con l’obbligo di uniformare le potenzialità dei piccoli calciatori a discapito del talento dei più dotati. Ciò in assoluto contrasto con l’obiettivo principale delle scuole calcio: quello di saper riconoscere e fare eccellere eventuali campioni in erba. Tale modello alimenta un tipo di competizione sbagliato e aggressivo, nemico di un approccio positivo all’agonismo. I giovanissimi allievi paganti giocano sempre meno per divertimento e voglia di condividere emozioni tra coetanei e sempre più perché devono arrivare a qualcosa, insicuri e frustrati da aspettative improprie.

In una recente intervista rilasciata al “Venerdì” di Repubblica, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso così si sfogava a proposito delle scuole calcio: «Ma fatela una passeggiata in queste scuole calcio: ci troverete genitori che sperano di diventare ricchi grazie al figlio calciatore». È facile immaginare – anche per via delle frequenti cronache riportate dai media – genitori esagitati che, dagli spalti, aizzano i giovanissimi giocatori a ogni infamità perché prevalgano sui compagni. Questa proiezione di ispirazioni, così violentemente invadente, delle famiglie, lungi dal mettere genuinamente al centro le esigenze e i desideri dei figli, ha l’effetto di disincentivarli al calcio, con il risultato che i bambini spesso finiscono con l’abbandonare i campi di lì a qualche anno. Tale familismo, becero e consumistico, trova la sua raison d’être nel mito di guadagni facili ed esorbitanti associato alla vita da nababbi dei campioni della serie A. In ciò i media – sempre più asfissiantemente concentrati sugli aspetti commerciali e mondani del calcio – hanno una grossa responsabilità. Forse qualcosa cambierebbe se l’educazione allo sport, e quindi anche al calcio, fosse assegnata alla scuola, attraverso un’attività didattica organizzata e strutturata, non limitata a poche ore settimanali e con pari dignità rispetto alle altre materie. Cosa potrebbe accadere se le scuole elementari e medie offrissero un indirizzo sportivo, calibrando con test attitudinali l’attività per ognuno dei bambini, senza comunque vietare loro la possibilità di cambiare disciplina? Offrire un servizio del genere consentirebbe a tutti, senza discriminanti economiche, di accedere all’attività sportiva, senza secondi fini, con il solo scopo di formare fisicamente e psicologicamente i bambini. Sarebbe un modo per farli crescere sani nel corpo e nella mente il più correttamente possibile e, perché no?, anche quello per sfornare piccoli campioni che possano competere un domani nelle competizioni internazionali. Se arrivare a ciò costituisce qualcosa di utopistico in un Paese come il nostro, o comunque non è affatto una prospettiva di breve periodo, si potrebbe, intanto, pensare che siano le stesse famiglie a prendere le redini del tempo libero dei figli, senza obblighi contrattuali e con la partecipazione fattiva dei genitori con compiti organizzativi e non più come semplici spettatori paganti.

[…] Tale partecipazione non solo rappresenterebbe un buon tentativo di sovvertire l’attuale andamento del calcio infantile (e anche di altri sport), ma favorirebbe la socialità dei genitori, avendo come base l’organizzazione di un’opera meritoria e fornendo ai genitori stessi una sorta di appagamento che solo le attività a scopo sociale sanno dare. Sognando Messi. La verità sulle scuole è un libro sincero, limpido, diretto, sullo stato dell’educazione calcistica in Italia e sull’educazione allo sport in generale. Stefano Benedetti conosce bene quello di cui scrive e ciò mette credito, tono, accoratezza e idealità alle sue parole. Il suo è un contributo che non lesina riflessioni più ampie attorno alla vita sociale contemporanea sempre più eterodiretta e omologata, ma che non si limita alla denuncia e cerca di individuare soluzioni fattibili, pensando a una collettività che scelga di farsi promotrice di nuove condotte all’insegna del civismo e della solidarietà. Un libro portatore di un dibattito necessario, rivolto a tutti coloro che sono investiti nel difficile compito della cura e dell’educazione e a tutti gli attori che fanno e animano la cultura calcistica e sportiva in Italia. Un libro che andrebbe, oltre che letto, molto meditato.





